Skip to content
Giuseppe Ungaretti
L’allegria
Il primo gruppo di 32 poesie, composte sul fronte del Carso tra il 1915 e 1916, viene stampato a Udine nel 1916 con il titolo Il porto sepolto.
Questi testi ripubblicati a Firenze nel 1919 con il titolo Allegria di naufragi.
Nel 1932 pubblica una seconda edizione del porto sepolto, fuori commercio
L’assetto definitivo viene fissato nell’edizione milanese del 1931, che prende il titolo L’allegria.
Nel 1969 l’opera entra infine a far parte del volume complessivo Vita d’un uomo. Tutte le poesie, edito da Mondadori. (Il porto sepolto trae ispirazione dai racconti di due giovani amici francesi.)
Il porto sommerso rappresenta per Ungaretti ciò che di segreto rimane in noi indecifrabile, ovvero quell’abisso nel quale il poeta deve immergersi per cogliere un frammento di verità e riportarlo alla luce.
Il secondo titolo, Allegria di naufragi, costituisce un’espressione ossimorica, perché i due termini sono in forte contrasto tra di loro.
Chiarisce anche questo Ungaretti: naufragi fa riferimento alla precarietà della condizione umana, allegria sta invece a indicare gioia d’un attimo, la gioia che l'animo umano prova nell'attimo in cui si rende conto di aver scongiurato la morte, drammaticamente contrapposto al dolore per essere uno dei pochi sopravvissuti al "naufragio”
La concezione della poesia
A partire dal 1942, riordina le sue poesie in un progetto unitario, e dà in titolo di Vita d’un uomo per sottolineare innanzitutto il carattere autobiografico. Afferma in un saggio: “Io credo che non vi possa essere né sincerità né verità in un’opera d’arte se in primo luogo tale opera d’arte non sia una confessione.
La concezione della poesia si fonda sulla convinzione che letteratura e vita siano strettamente connesso tra loro e che in tale rapporto di interdipendenza la letteratura abbia un ruolo privilegiato, in quanto assume un valore religioso è capace di abolire il tempo storico e di svelare il mistero eterno dell’esistenza.
Per Ungaretti la poesia consente all’uomo di liberarsi dal peso della memoria, recuperando, in questo modo, l’innocenza, ovvero la condizione di purezza originaria.
Ritiene che il mistero eterno dell’esistenza non possa essere interamente svelato attraverso il discorso continuo.
Porto sepolto: Il poeta diventa una sorta di veggente e di sacerdote della parola, un essere privilegiato a cui è concesso di esprimere l’inesprimibile, rivelando il fondo segreto della realtà, seppur in modo frammentario e discontinuo.
I temi fondamentali
Il tema centrale della raccolta è la guerra. Come dice Ungaretti in una sua dichiarazione:
Nella mia poesia non c’è traccia d’odio per il nemico, né per nessuno; c’è la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini nella sofferenza.
C’è la volontà d’espressione, necessità d’espressione, c’è esaltazione, nel Porto sepolto, che è moltiplicato dalla prossimità e dalla quotidiana frequentazione della morte.
L’esperienza vissuta in prima persona al fronte, dove ogni aspetto della vita è ridotto all’essenziale, diventa per Ungaretti l’occasione per recuperare l’innocenza.
L’aspirazione a recuperare l’identità perduta e a far parte di una comunità concreta di uomini si ricollega a un altro gruppo di temi e motivi fondamentali della prima raccolta poetica ungarettiana: il nomadismo, l’esilio, il viaggio e la ricerca della patria lontana.
Anche il concetto di patria, è un mitico “paradiso terrestre” in cui il tempo è abolito e sopravvive appunto quell’innocenza originaria che il poeta.
Le soluzioni formali
L’esperienza lacerante della guerra e della vita in trincea segna una vera e propria svolta nel percorso poetico di Ungaretti, poiché il contatto diretto con una condizione esistenziale convince il poeta di adottare uno stile altrettanto spoglio e privo di ornamenti superflui.
La maggior parte delle parole proviene dal linguaggio comune ma si arricchisce di significati grazie alle originali scelte stilistiche e metriche adottate. Ungaretti procede alla distruzione della metrica tradizionale attraverso l’adozione di versi liberi per lo più brevi, talvolta composti da una sola parola.
Sul piano della lettura immerge un’elevata frequenza di pause e silenzi che caricano la funzione di un intenso potere evocativo.
Le strofe sono per lo più costruite dalla sola frase principale o da due o più frasi coordinate, mentre la presenza delle subordinate è piuttosto rara, ciò elimina pressoché totale dei connettivi logici. La punteggiatura è del tutto assente.


Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
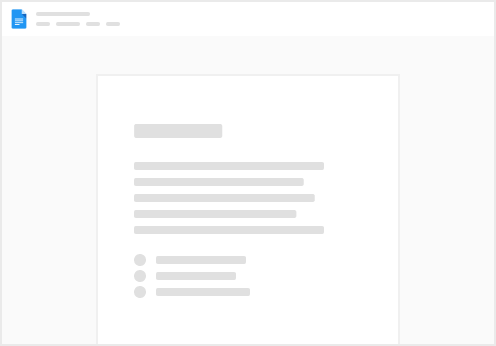
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.